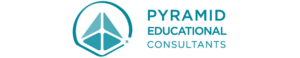
La cesura tra letteratura e pratica clinica è un problema annoso che può costituire un ostacolo talvolta alla diffusione di buone prassi e di strumenti utili. Non sempre i professionisti che lavorano sul campo hanno la possibilità di incontrare direttamente ricercatori e scienziati, di entrare in dialogo e\o di rimanere aggiornati sulla letteratura disponibile.

Oggi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Sara Guidotti e poter far sì che sia direttamente lei a condividere gli esiti della ricerca condotta nel suo gruppo di lavoro!
Carlo Pruneti, docente di Psicologia Clinica e Psicopatologia dell’Università di Parma, Gabriella Coscioni e Sara Guidotti, Laboratori di Psicologia Clinica, Psicofisiologia Clinica e Neuropsicologia Clinica, hanno recentemente pubblicato un lavoro davvero interessante sulle pratiche di evidenza oggi disponibili sull’autismo.
L'obiettivo della loro ricerca è stato quello di valutare l'efficacia degli interventi di terapia comportamentale nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico (ASD). Lo studio di revisione ha preso in esame solo studi robusti, studi randomizzati controllati, che potessero cioè dare un dato inequivocabile. E attraverso questa lente hanno trovato come i trattamenti su base comportamentale come PECS, DTT, PRT, TEACCH, ESDM e EIBI, hanno in generale un impatto positivo.
E questa è già un’ottima notizia ma non è la sola!
Quello che la loro ricerca ha anche evidenziato sono una serie di ulteriori outcome positivi di questi programmi:
-
I protocolli naturalistici che impiegavano PRT e PECS hanno migliorato i sintomi dell'ASD in generale, non solo l’area della comunicazione.
-
L’ESDM ha particolare impatto sul linguaggio soprattutto nei bambini in età prescolare,
-
Interventi strutturati e integrati, come la BEI e TEACCH, producono un miglioramento del funzionamento adattivo generale.
-
Combinare il DTT con un programma TEACCH ha prodotto maggiori benefici nei domini linguistico, affettivo-sociale e dell'autonomia personale.
-
PRT e Il PECS ha migliorato significativamente le capacità di comunicazione sociale in sole 15-40 ore nell'arco di sei mesi.
Sara Guidotti ha recentemente acconsentito a incontrarci e a rispondere ad alcune domande!

Che cosa fate all'università di Parma e come siete arrivati a fare questa ricerca?
Ci occupiamo di disturbi mentali, siano essi a carico della dimensione emotiva, cognitiva o comportamentale. L’obiettivo che perseguiamo, sia nell’ambito della ricerca che nella pratica clinica, è quello di adottare un approccio multidimensionale in grado di mettere insieme differenti sfaccettature della patologia (processi cognitivi interni, comportamento manifesto ed assetto emotivo e psicofisiologico). Questo sia per quanto riguarda l’aspetto della valutazione che quello della rivalutazione al termine dei trattamenti. Il nostro interesse quindi riguarda tutti quelli che possono essere gli interventi cognitivi e comportamentali per vari disturbi a carico dell'assetto cognitivo, come quelli dello sviluppo neurocognitivo come per esempio l'autismo. L'interesse nei confronti di questa ricerca è nato principalmente dal mio tutor di dottorato, il mio supervisore che è uno psicologo, psicoterapeuta e docente di psicopatologia generale e dello sviluppo. E aveva proprio come obiettivo quello di fare un'analisi degli interventi evidence-based per questo tipo di patologia. Prima del dottorato, ho lavorato in un centro privato dove facevamo terapia Aba per bambini con disturbi del neurosviluppo, molti avevano una diagnosi di autismo, e quindi anche io ero curiosa di fare un'indagine sistematica di quelli che erano gli studi evidence based.
In letteratura viene più volte sottolineato quanto la terapia Aba sia efficace, non mettendo però adeguatamente in evidenza le differenze che ci sono rispetto ad altre nazioni. La terapia Aba, per come la conosciamo noi in Italia, è effettivamente una minima parte di quello che in realtà viene fatto per esempio negli Stati Uniti dove ci sono delle strutture specializzate, operatori formati per fare anche interventi intensivi. In questo tipo di strutture, gli interventi comportamentali vengono implementati grazie al supporto del sistema sanitario nazionale con un'intensità (in termini di ore settimanali) decisamente più elevata rispetto a quella che ci possiamo permettere noi nei centri privati dove l'aspetto economico è a carico delle famiglie.
Il nostro obiettivo è stato quello di analizzare lo stato dell'arte e, come abbiamo riportato nelle conclusioni, quello di far notare alla comunità scientifica e anche però ai professionisti sanitari che bisogna fare di più, soprattutto qui, Italia. Evidenziando a livello scientifico quello che in realtà rimane un po' sottinteso nel senso comune o comunque viene dato per scontato: si parla tanto di intervento precoce, di intervento intensivo precoce però poi, di fatto, abbiamo notato che gli studi randomizzati e controllati sono davvero pochi, le considerazioni che diamo andrebbero sostenute e arricchite da altri studi ancora.
Qual è la tua opinione rispetto allo stato dell'arte, della qualità della ricerca che viene svolta nell'ambito?
Quello che abbiamo notato è che la qualità non è molto alta. Vengono rispettati standard indicativi di rigore scientifico e metodologico solo da pochi autori. Quindi, quando poi vengono definiti criteri specifici per selezionare i lavori di alta qualità, per esempio nelle review, il numero di lavori che vengono contenuti si riduce drasticamente.
Rispetto ai pochi autori che riescono ad avere una qualità molto elevata, la raccomandazione è quindi quella di non scoraggiarsi, di continuare a fare ricerche in questo ambito e raccogliere dati. Coinvolgere gruppi di bambini sempre più ampi e riuscire ad avere dei campioni numerosi, che in qualche modo possano rappresentare quella che è la popolazione generale, può essere davvero molto importante.
Scorrendo l'articolo quello che abbiamo notato anche è che viene citato PECS e i suoi outcome rispetto alla comunicazione. Viene citato però anche che potrebbe avere alcuni effetti positivi anche rispetto ad aspetti più sociali, sull'interazione. Quali potrebbero essere i futuri sviluppi di ricerca?
L’analisi degli outcome evidenziata nella nostra review ha messo in luce che l’utilizzo delle PECS potrebbe avere effetti positive sui bambini affetti da disturbi del neurosviluppo, e in particolare sull'autismo, prendendo in considerazione la qualità dell'interazione madre-bambino. Abbiamo notato che gli interventi che coinvolgono i caregiver (nella maggior parte dei casi si tratta dei genitori) hanno mostrato risultati promettenti, nonostante sia un'area piuttosto recente ed effettivamente ancora in via di sviluppo. Riteniamo che futuri studi possano prendere in considerazione delle misure della qualità della comunicazione tra il bambino ed i suoi genitori e poi, eventualmente, anche i suoi coetanei. Effettivamente, implementare interventi in grado di agevolare la generalizzazione dei risultati ottenuti dall’operatore nel suo setting è la direzione che sarebbe opportuno considerare.
Quali tipologie di ricerca vi piacerebbe vedere in Italia?
Mi piacerebbe che in Italia venissero replicati studi ove l’ABA viene applicato ad alta intensità. È importante sottolineare che, altrimenti, si sta facendo riferimento a due cose differenti tra l’ABA applicato ad alta intensità, a cui si fa riferimento parlando di letteratura scientifica, e quello effettivamente implementato nella pratica clinica italiana. Portare il modello americano di ABA in Italia, senza però rispettarne gli stessi standard, può non consentire il raggiungimento degli outcome descritti dai ricercatori. Per esempio, applicare un tipo di intervento con un paio di sedute settimanali da due ore può essere molto diverso da quello applicato in strutture residenziali o semi-residenziali con un’intensità del trattamento che può arrivare fino alle 30 ore settimanali.
Pensi che le linee guida italiane abbiano accolto le evidenze della ricerca?
Le hanno accolte sì, la terapia ABA viene più volte riportata come trattamento elettivo, però poi a livello applicativo sostanzialmente non vengono sostenute dal sistema sanitario nazionale. La terapia tradizionale, per esempio, comprende solo la logopedia o comunque percorsi di psicoeducazione.
Nel vostro articolo viene citato il fatto che trattamenti più accessibili possono aumentare l'accessibilità al trattamento. In questo senso intendete l'accessibilità economica o ci sono delle altre barriere a cui fate riferimento?
Il riferimento era prevalentemente rivolto ad altri aspetti, non soltanto a quello economico. In un contesto naturale è più facile che le insegnanti e le educatrici familiarizzino con quelli che possono essere degli strumenti per loro nuovi. Appunto, perché almeno in Italia, insegnanti ed educatori non sono specificatamente formati sulla terapia ABA. Quindi selezionare strumenti che possono essere trasversali ai vari contesti frequentati dal bambino con autismo, come le PECS, che possono essere benissimo applicate all'interno di vari contesti (terapia, scuola, casa, ecc.) può essere importante anche per agevolare il lavoro di rete e inserire il lavoro dei terapisti ABA facilitandone la conoscenza. È possibile, in questo modo, incuriosire i professionisti e, di conseguenza, formarli piuttosto che creare divisioni nette tra quelle che sono le attività previste dall’intervento ABA e quello che si fa a scuola. Questi strumenti possono favorire il lavoro di equipe favorendo la “mescolanza” di professioni e di tecniche che facilitano poi la generalizzazione degli apprendimenti.
Un aspetto secondo me rilevante è proprio questo: ricordo molto bene che cosa significa lavorare con bambini a sviluppo atipico e insegnare loro a utilizzare le PECS quando alle problematiche comportamentali si associa un importante deficit cognitivo (per esempio, con elevata distraibilità e impulsività che rendono molto difficile attirare l’attenzione del bambino e canalizzarla sullo stimolo oggetto dell'insegnamento). Possiamo immaginare le difficoltà di un operatore poco formato, o non specificatamente formato nella terapia ABA, che si trovi nella stessa situazione. Capisco la difficoltà e la frustrazione che ci può essere nel gestire aspetti legati alla disattenzione oppure all’impulsività: bisogna davvero riuscire ad avere un buon controllo della situazione ed arrivare a consolidare un buon livello di collaborazione con il bambino in modo che possa seguire le istruzioni che gli vengono impartite. Quindi, secondo me, è importante evidenziare tutti questi aspetti e fare formazione a tutto tondo, anche su quegli elementi che possono interferire nel processo di apprendimento. Problematiche comportamentali e cognitive di questo tipo possono anche essere accompagnate da alterazioni emozionali, come per esempio gli scoppi di collera, che possono, a loro volta, frustrare l'operatore e disincentivarlo nell'utilizzo di questi strumenti. Solo con una prospettiva olistica, o con un approccio multidimensionale, è possibile comprendere che lo scarso utilizzo di strumenti, come le PECS, possa essere almeno in parte collegato ad un insegnante o ad un educatore che si trova in difficoltà a causa della scarsa formazione.
In conclusione..
Unica cosa che mi sento di precisare è che, per quanto io lavori nell'ambito della ricerca e insieme ai miei colleghi mi sia focalizzata nell'analisi degli studi randomizzati controllati e per quanto abbia sottolineato nella review l'importanza del rigore metodologico, è importante utilizzare con flessibilità gli strumenti.
A volte il rischio è che passi il messaggio che l'analisi del comportamento si debba fermare a quello che è il comportamento, con l'analisi degli antecedenti e delle conseguenze, tralasciando tutto quello che è l'aspetto cognitivo ma soprattutto emozionale. Soprattutto in questi bambini, non possiamo dimenticarci che c'è un'emotività molto forte e che un “comportamento problema" può essere anche uno scoppio di collera motivato da elevata frustrazione nel raggiungimento del rinforzatore, per esempio. Ma la rabbia, che si manifesta con scoppi di collera, è indice di sofferenza per il bambino, a livello mentale ma anche fisico, in quanto supportata da una forte attivazione psicofisiologica. D’altra parte, per l'operatore può essere molto difficile gestire l’emotività del piccolo paziente e della propria, in quanto il timore di sbagliare a individuare l'antecedente o le conseguenze del comportamento e, allo stesso tempo, la paura che il bambino possa fare del male a sé stesso o ad altri possono rendere molto complesso il lavoro negli ambiti di applicazione delle terapie ABA.
Per quanto difficile e complesso, quindi, è un nostro imperativo farci carico di questi questi aspetti e incoraggiare la formazione sulla gestione dei sintomi cognitivi e comportamentali ma anche dell’emotività.
